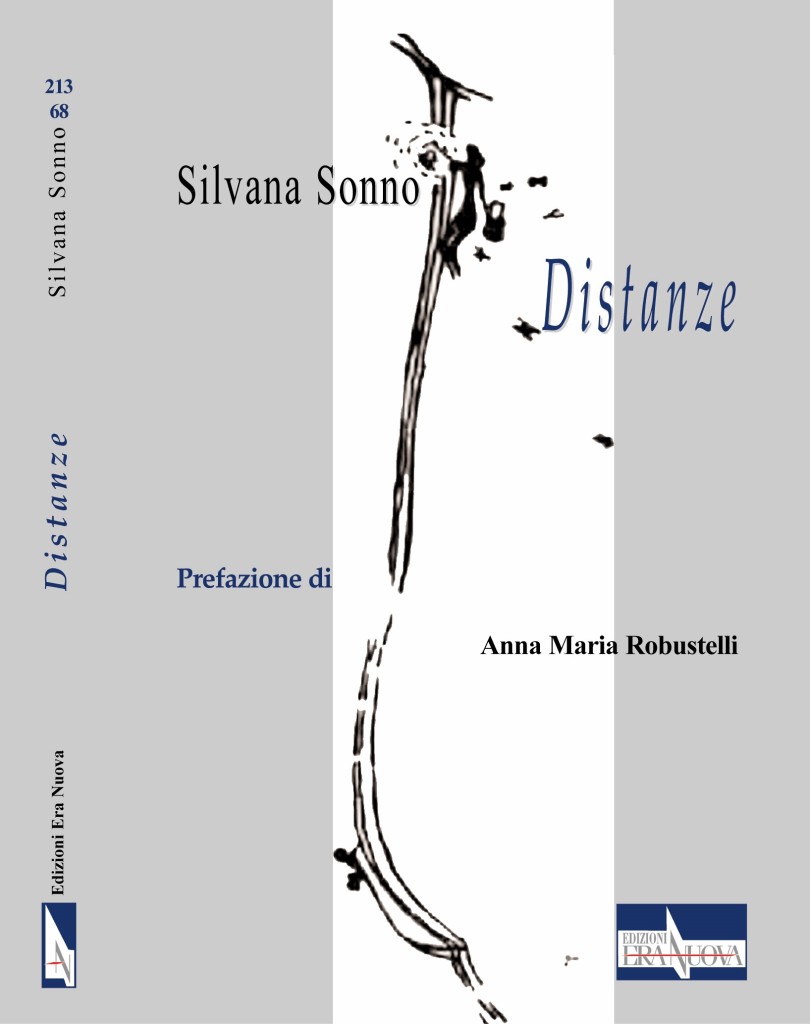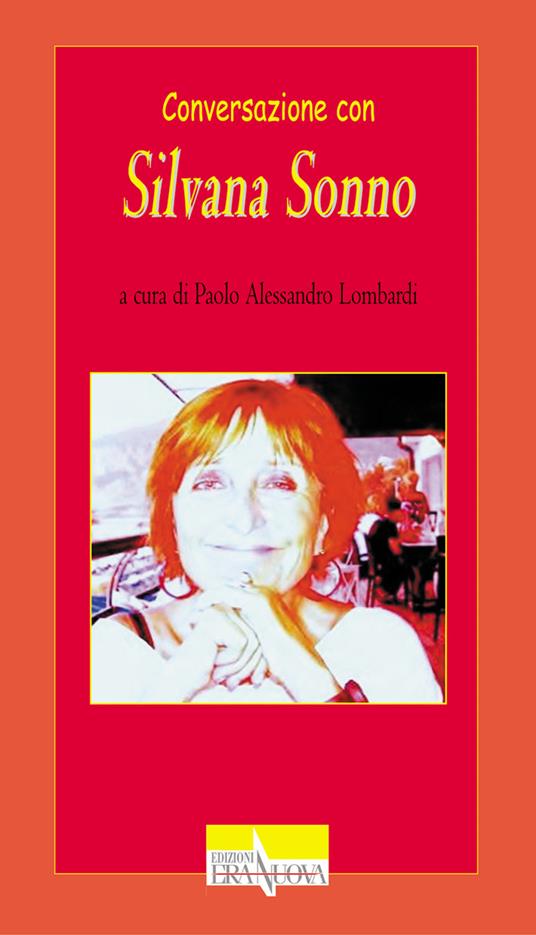Recensione di Silvana Sonno per Un gatto senza vanità di Nicoletta Nuzzo, Giovedì 17 novembre 2022, Biblioteca San Matteo degli Armeni, Perugia
Libro complesso, elegante, sofisticato. Insolito.
E’ un testo difficile da raccontare, perché non è solo narrazione, ma anche suggestione; il tempo vi scorre in un’ alternanza di passaggi tematici, a volte solo frammenti, sempre sostenuti da una scrittura lirica, di alto potere espressivo.
Provo a sintetizzare parlando di un raffinato racconto a tappe, dove la presenza di un gatto consente a Nicoletta Nuzzo una particolarissima “ricerca del tempo perduto”, testimone lui – Ugo il suo nome – di una identità che si è formata dentro una comunità totalmente femminile, in un Sud che è stretto dentro una cultura patriarcale, misogina, ricca di pregiudizi, forgiata in stereotipie maschili, ma è anche il luogo mitico dell’infanzia, e anche dell’infanzia del mondo mediterraneo, luogo sacro alle antiche dee femminili, tra cui primeggia Diana, la dea lunare che torna nel libro sotto le spoglie di una gatta bianca, nell’ultima parte del testo.
Ma chi è Ugo? Ugo è un gatto di casa, che, come scrive Nicoletta, fin dall’inizio del suo apparire appartiene all’araldica famigliare, quando si mostra nel suo distendersi sul tappeto della casa natale, per rilassarsi, come un gattopardino in posa all’interno dello stemma di famiglia, col ventre allargato ed il piedino che scivola languidamente fuori.
Una divinità domestica, dunque, non come lo Stregatto di Alice; non evapora, non galleggia nell’aria, non muta forma, non ghigna, anzi è una presenza stabile, solida, nella vita di Nicoletta e delle sue sorelle, che per Nicoletta acquista il carattere simbolico, metaforico di “Custode della Soglia”, abitatore del Mondo dell’Oltre Tempo, punto di riferimento costante delle sue riflessioni e delle sue ossessioni; e per questo può divenire Guida e Alleato psichico nel processo di individuazione femminile di cui questo libro si fa testimonianza.
Nel titolo si dice che Ugo è un gatto senza vanità. Cosa si intende con questo? Io intendo qui vanità in senso etimologico; vano: l’inconsistente, il vuoto. Ugo, come ce lo presenta Nicoletta, non ha vuoti. Il suo è un corpo senza colpa che non ha ereditato il peso dell’espiazione del peccato originario ed è intero. Intero perché sente e pensa con tutto se stesso, senza separazione tra testa e corpo, come accade ai viventi non umani, dove, scrive Nicoletta, “il divino si manifesta con una immediatezza che spesso manca a noi umani, invischiati e intrappolati come siamo anche dalla nostra stessa “cultura”.
E ancora, rivolta a Ugo: “…. Non ti stressare con l’ossessione di un corpo che deve essere utile, che deve comunicare…il corpo sa più cose di quelle che noi possiamo conoscere, lasciamogliele dire, ed è questa una cosa che tu sai fare quando vivi come sei, ed è lì la tua perfezione” .
Dunque Ugo è perfetto e per questo diventa l’amico complice di chi cerca l’interezza e rifugge le falle di un corpo di donna aperto, lacero, esposto, un corpo incubo da esorcizzare con le parole, con l’arte. Una cicatrice inconsolabile segna la perdita del cordone con la madre terra, spinge alla ricerca delle parole davanti a una madre di carne, ma muta, silenziosa per anni, che scrive la sua storia con le mani abili da sarta e traspone nella confezione del cibo per le figlie la verità originaria per la quale non ha lingua.
“Tu, mia madre, eri stata la divinità che mi aveva creato, il tuo soffio vitale aveva fatto di me la creatura dei tuoi sogni: incorporea e perfetta… quando tempo dopo tutto cominciò ad addensarsi oscurandosi nella materia anche tu diventasti densa e oscura…poi tu cominciasti a rinnovare i fasti della nascita trasformando tutto in cibo per me, per noi due. Quelle erano le tue parole per me, parole ritornate cibo, parole da mangiare che avrebbero riportato per sempre dentro di me l’onda calda della verità originaria”.
Le parole così tanto cercate, per Nicoletta diventano persone, come ci dice anche James Hillman: attivano e disattivano emozioni, appaiono come angeli, ma possono abbandonare e allora nella loro assenza è di nuovo l’orrore, la solitudine, il peso dell’esistenza che grava sul corpo muto; solo le parole possono contrassegnare i veri “momenti d’essere”, diventare lingua per dire le nuove conoscenze della crescita combattere la paura e le aggressioni, esterne e interne; per dirsi.
E Ugo in tutto questo?
Ugo corpo intero è lui stesso parola, la sua bellezza è parola che consola. Anche Ugo, però, ha i suoi fantasmi, i suoi timori, ma nei millenni – dai gatti mitologici, divinità infere dell’Egitto, come la gatta Bastet scolpita splendidamente nel porfido nero – ha imparato l’arte di schivare il pericolo, mimandolo, rappresentarlo con un po’ di distanza, forse farselo amico. Diventa un po’ artista, Ugo, nelle sue pantomime e forse ci si diverte anche un po’, scrive Nicoletta.
E forse è un po’ quello che fa anche Nicoletta, con questo libro e con gli altri. Tutti condotti a essere luogo dove si traspone la “vera casa della memoria”, quella di Diso, il paese salentino dove sorge la casa dell’infanzia e dove per molte estati anche Ugo si trasferiva con le sue amiche da Modena, la città dei portici dove ha vissuto.
La casa di Diso, che conserva e difende, dove il rumore del mare è voce che salva e molto del passato (la sua memoria) è rimasto lì, sospeso. Lo si può raccogliere alla bisogna e farsene scudo, protezione.
Riporto dal testo uno stralcio che presenta la complicata costellazione familiare di Nicoletta ai suoi esordi:
Neanche lo sguardo
“Nella prima stanza a Diso, dove adesso ci riuniamo in salotto per guardare la televisione, mio padre vide per la prima volta mia madre. Lui stava chiedendo al suo destino un’altra possibilità: una pagina bianca, intatta dove scrivere un’altra storia di se stesso, con l’aiuto questa volta dell’esperienza. Così sposò mia madre: e lei giovane molto più giovane di lui voleva dire immunità e ancora altra immunità con noi quattro figlie tutte nuove, ma tutte donne. Lui non voleva pericoli per noi e i pericoli erano i maschi che circolavano non solo davanti ai bar, ai negozi, nella piazza del paese ma dentro casa come amici, cugini, parenti e naturalmente in ogni parte del mondo. Un’ossessione: non poteva stare tranquillo, ma neanche noi con la custodia di un corpo da mantenere come ci era stato consegnato cioè puro, anzi intatto. Non era un compito facile. A volte bastava uno sguardo di fuori ma anche dentro di sé…era difficile portare con sé un corpo di donna, pieno di confusione dove si mescolavano grazia e tensione, e questo doveva avvenire di nascosto… e non era nuovo questo sogno di grazia. Nel tempo quanti busti e scarpe strette, quanto sudore e fatica nascosta per quella “superiore” parte nella rappresentazione!
Un corpo incrinato da troppe presenze: anche quella dei mariti possibili e dei figli possibili.”
Un futuro di donna che sembra già iscritto come destino nel corpo e a cui è necessario restituire la purezza degli inizi, quando la Grande Madre stabiliva ordine ed armonia nel cosmo millenario. E ritrovarlo intero per sé nei gesti e nei riti della scrittura che viene finalmente a difendere, contro la cultura patriarcale, una corporeità che è cella sacra dell’origine.
Nel suo dipanarsi il testo di Nicoletta Nuzzo svela un percorso interiore, non sempre lineare, che è anche un pellegrinaggio, con a fianco la piccola presenza di un emissario dell’Oltremondo a ricordarle che ci può essere salvezza.
Silvana Sonno
Un gatto senza vanità di Nicoletta Nuzzo, Rupe Mutevole Edizioni, collana Trasfigurazioni, ristampa 2021